
“Che cosa non mangerò a Marrakesh!” dice poco prima di partire per il viaggio di nozze in Marocco. Immagina delle feste da Mille e una Notte, la cucina araba – scrive – è “come un poema in cento piatti”, “con il latte di mandorle e il tè alla menta bevuti nei giardini illuminati dalla luna, dove crescono le rose, la menta e il gelsomino giallo e dove mormorano le acque delle fontane ricoperte di mosaici.” Il principe Al-Glawi, suo ospite, dispone di ottanta cuochi e di molte schiave negre, “morbide come la frutta”, che servono a tavola. E, anche se Colette ha sempre privilegiato la cucina francese tradizionale, non si tirava indietro davanti a cucine di altri paesi.
“Cena presso il ciambellano del Sultano. Mosaici e fiotti di luce bagnano i muri. Bella a forza di essere vasta, la dimora accoglie anche la luna, che cola dall’alto del cortile aperto, dove mormorano le acque. La cena araba comincia con una minestra pepata, poi abbiamo:
La pastilla, pasta sfoglia all’uovo e il pollo dolce.
I piccioni.Il pollo alle mandorle fresche.
Il mechouï.
L’alose.
Il montone ricoperto di olive e di scorze di limone.
I fondi di carciofo appoggiati su della carne molto cotta.
Del montone, servito con le mele verdi cotte.
Il couscous con i ceci e l’uva passa, accompagnato dal latte cagliato.
Il turbante del Cadi.
Le orecchie del Cadi.
L’aranciata senza acqua.
Il caffè, il tè alla menta.
E, più tardi, il latte di mandorle.
Questo è il lungo elenco dei piatti della cucina marocchina che troviamo in Prisons et paradis, libro nel quale si parla molto di cucina. La pastilla, è una pasta sfoglia ripiena di pezzi di piccione, di uva passa e di mandorle. Il mechouï è l’agnello fatto cuocere intero, allo spiedo, sulle braci di un fuoco di legna. L’alose è un pesce che somiglia alle nostre sardine.
Anche nel libro De ma fenêtre c’è un riferimento a quello che la scrittrice ha mangiato nel corso di un suo viaggio nel deserto algerino.
“Ho incontrato il pane cotto in padella durante una sosta in una specie di frazione tutta rosa, il rosa tenue del deserto. In lontananza brillava la Montagna del Sale.
Abbiamo avuto il mechouï presso un caïd. Mi guardo bene dal sottolineare la prelibatezza della carne arrostita a puntino, bagnata con l’acqua salata con il salgemma… Mancava il pane ed è stato fatto sul momento. Per quel che posso testimoniare, alla bella farina profumata è stato aggiunto solo il lievito e un po’ di sale sciolto nell’acqua dell’impastatura. Invece di mettere il pane nelle forme, come si fa in Europa, si distribuisce la pasta in due o tre tegami… Non ho scoperto altre magie. Ma ho assaporato un pane dorato sopra e sotto, più simile a una focaccia croccante che al pane…”
Assapora anche il latte di mandorle, di cui fornisce la ricetta in Prisons et paradis, bevanda che non abbandonerà più per il resto della vita.
“Per 2 litri di latte di mandorle occorre più di 1 chilo di mandorle fresche pelate. Pestatele in un mortaio di marmo con una piccola quantità di zucchero. Aggiungete goccia a goccia l’acqua necessaria all’emulsione. Lasciate il mortaio, coperto da un panno, e il suo contenuto, riposare al fresco per la notte successiva. Il giorno dopo filtrate in un sacchetto di batista o di mussolina dalla trama fitta. Assaggiate, aggiungete ancora un po’ di zucchero e l’acqua che manca a fare i due litri. Se servite subito la bevanda, potete sostituire l’acqua con del latte fresco. Non agitate mai il latte di mandorle, ma lasciate galleggiare sulla sua onda azzurrina, cremosa, una foglia di cedronella, verde, appena immersa, sottile come una giunca cinese. E non dimenticate – tutto è perduto senza di essa – la goccia di essenza di rose, una goccia, una sola…”.
Sulla terrazza della casa di Saint-Tropez, all’ombra del glicine e della vite, pranza con le specialità provenzali: lo scorfano alla griglia, i ravioli di mamma Lamponi e il riso con i favouilles, i piccoli granchi piatti e verdi, raccolti dai pescatori sulle rocce, con cui beve un fresco vino rosato locale. Si serve abbondantemente anche di melanzane appena raccolte nell’orto, consumate come antipasto mescolate ad altri ortaggi o fatte friggere. Le definisce karagheuziennes, dal nome di Karagoz, personaggio del teatro d’ombre turco, protagonista di farse, che, secondo quello che scrive Théophile Gautier in Costantinopoli, ricorda un po’ il nostro Pulcinella.
Anche qui, come a Parigi, i pasti di Colette cominciano con l’aglio, al posto d’onore fra i sapori rustici, strofinato su una crosta di pane fresco leggermente spolverata di sale grosso e terminano con un dolce, possibilmente alla frutta.
A volte va a fare pic nic, come racconta in Prisons et paradis.
“È bello essere vicini a una sorgente, tendere verso di lei un bicchiere vuoto o la pancia di una bottiglia piena, mentre si apre il paniere dei fichi viola e si taglia a fette la torta con le acciughe.”
La sera, va con gli amici a bere il vino bianco al ballo dei pescatori o raggiunge il piccolo ristorante del porto per rendere omaggio alla bourride, la zuppa di pesce fatta con gli scorfani, la rana pescatrice, il nasello, il branzino, la triglia, al cui brodo di cottura fa aggiungere le teste dei pesci. Oppure mangia il sotto coffi, come racconta nel Journal à rebours.
“- È famoso questo pesce! Come lo chiamate?-
- Chi lo sa? Noi qui lo chiamiamo con il nome di sotto coffi. Sotto questa veste provenzale, avreste riconosciuto il nome del volgare stockfish? Io ci ho messo del tempo.-”
In Prisons et paradis ne descrive la preparazione.
“È una ricetta? No. È una preparazione primitiva, vecchia come l’ulivo, come la pesca con il tridente. Nessuna cottura ha mai richiesto meno preparativi, ciò che è essenziale è l’esecuzione. È sufficiente una foresta provenzale o, perlomeno, meridionale. Fate rifornimento di legna scelta: ceppi cornuti di olivo, fascine di cisto, radici e rami di alloro, tondelli di pino stillanti resina dorata, cespugli minuti di terebinto, di mandorlo, senza dimenticare il sarmento di vite. Preparate la pira fra quattro grosse schegge di granito e accendete il fuoco. Osservatelo mentre arde, rosso, bianco, ciliegia, con i bordi azzurri e dorati… Al momento del crepuscolo, il cielo verde si tinge del colore del lago. La fiamma si riduce, si distende; voi avete certamente sottomano un bel pesce del mediterraneo, o anche più di uno, sventrato... Avrete acquistato a Saint-Tropez uno scorfano mostruoso, a gola di drago, o avete portato da Tolosa i maliziosi cefali dal dorso nero, nel cui ventre cavo non avrete tralasciato di strofinare una fetta di lardo. Bene. Preparate il vostro balai, io chiamo così il mazzetto odoroso di alloro, di menta, di pebredai, di timo, di rosmarino, di salvia, che avrete legato prima di accendere il fuoco. Sistemate dunque il balai nella pentola, in modo che sia immerso nell’olio d’oliva migliore mischiato all’aceto di vino – qui è ammesso solo l’aceto rosa e dolce. L’aglio – pensavate, ingenui, che ci fossimo dimenticati di lui? – pestato fino a raggiungere la consistenza della crema, ravviva come si deve la miscela. Un po’ di sale, abbastanza pepe. Attenzione. Ben presto il fuoco non è più che brace. Uno spesso strato di braci che canta sommessamente, dei tizzoni che ardono ancora per un po’; una fumata traslucida, leggera, porta alle vostre narici l’anima incenerita della foresta… è il momento di dare il calcio magistrale, che manda lontano la copertura, i tizzoni, la fumarola, che porta alla luce e livella il carbone ardente di un rosa uniforme, mette a nudo il cuore puro del fuoco sul quale ansima un piccolo spettro igneo, bluastro, ancora più bruciante di lui.
Si pianta a perpendicolo, nel bel mezzo dell’inferno, una vecchia griglia alta tre piedi, salamandra contorta al servizio della fiamma, che accoglie il pesce benedetto dalla salsa. Certo, per ottenere un buon risultato ci vuole l’esperienza e la stregoneria dell’uomo del Dom, di cui non si vede che l’ombra e il cui braccio nero umetta e asperge il pesce senza sosta, per… Per quanto tempo? L’uomo nero lo sa. Non conta i minuti, non consulta orologi, non assaggia, sa. È questione di esperienza, di divinazione. Se non possedete un po’ di stregoneria, non è il caso di immischiarvi in affari di cucina.
Il ‘pesce alla griglia con pedata’ salta dalla vecchia graticola nel vostro piatto. Vedrete che è rigido, rivestito di una pelle croccante, che si sfalda scoprendo una carne bianca, soda, il cui sapore ricorda il mare e i balsami silvestri.
Scende la notte resinosa. Sul tavolo, la luce fioca della lampada rivela il colore granata del vino che riempie i bicchieri…
Sottolineate con una libagione riconoscente questo momento felice.” Spalma la salsa aïoli sulle fette di pane, alternandola all’anchoïade, la salsa d’acciughe in olio d’oliva. Conclude il pasto con un bel melone verde o con una torta di fragole selvatiche, di cui è molto golosa, e che va a raccogliere personalmente.
“Un’onda molle di profumo guida i passi verso la fragola selvatica, rotonda come una perla, che matura qui in segreto, annerisce, trema, cade e si dissolve lentamente in una soave decomposizione, il cui aroma si mescola a quello di un caprifoglio verdastro, frammisto al miele, a quello di un girotondo di funghi bianchi.” scrive nel libro I viticci.
Poi nuota, cura il giardino, fa delle passeggiate, addestra le farfalle a bere il vino rosé sulle sue dita.… “Com’è dolce vivere fisicamente e sentir tornare la forza muscolare che si credeva perduta…”. Si accorge di “star diventando molto meridionale”, come racconta ancora nello stesso testo.
“D’estate, le merende nel giardino caldo, le meringhe farcite di panna, i lamponi, si perdevano in un eccesso di luce e calore.”
I pic nic li fa anche a Parigi.
“A febbraio non mancano le giornate miti. Noi prendevamo le biciclette, un pane fresco imbottito di burro e di sardine, due paste sfoglie con la salsiccia comprate in una salumeria vicino a La Muette, delle mele, legavamo il tutto a una fiaschetta impagliata, piena di vino bianco… Il caffè lo bevevamo dalle parti della stazione di Auteuil, nero e insipido, ma bollente, e sciropposo a forza di zucchero… Pochi ricordi sono per me così sentimentali come quelli di quei pasti senza coperti né tovaglia, di quelle passeggiate su due ruote.” ricorda in Chambre d’hotel.
A volte parte per dei viaggi gastronomici nei ristoranti di provincia. In Bella-Vista racconta, nel suo stile inconfondibile, una di queste esperienze.
“Nella sala da pranzo, che non era per nulla monumentale, ma bassa e debitamente oscurata, una dozzina di tavolini sparpagliati, ricoperti di tela basca grezza, tranquillizzarono la mia in socievolezza. Niente burro nelle conchiglie, nessun maître in frac nero-verdastro, nessun portafiori parsimonioso contenente un’antemide, un’anemone malandata, un ramo di mimosa. Ma un grosso dado di burro ghiacciato e, sul tovagliolo piegato, una rosa del rosaio rampicante, una sola rosa dai bordi un po’ strinati dal mistral, una rosa che sono libera di appuntare sulla mia maglietta o di mangiare come antipasto.
In mezzo ai tavoli, Lucia, distratta, stanca e incipriata, portava l’omelette alla cipolla, le frittelle di cervella e lo stufato di manzo.”
Viaggi gastronomici un po’ particolari sono le sue spedizioni nei boschi per procurarsi la materia prima di uno dei suoi piatti preferiti: i tartufi, che voleva fossero serviti nella pentola, con il loro sugo profumato. Con al guinzaglio una piccola scrofa, “un’artista nel suo genere”, va alla ricerca dei preziosi tuberi, “gemme di una terra povera”, che, una volta a casa, si mette a spazzolare minuziosamente di persona, rifiutando di affidare ad altri questo prezioso incarico.
“Troppo caro per noi – racconta in Prisons et paradis - d’inverno il tartufo del Périgord cedeva il posto a quello del Puisaye, grigio, abbastanza insipido, il cui profumo trae in inganno l’ignorante. Ma grigio o nero che sia, avvolgete il tartufo, dopo averlo spazzolato, in un cartoccio di carta oleosa, poi fatelo scivolare dentro a un ponticello di cenere caldissima, molto vicino alla fiamma.”
In alternativa:
“Bagnato con del buon vino bianco, molto secco – riservate lo champagne ai banchetti, il tartufo può fare a meno di lui – salato senza eccessi, pepato con tatto, cuocerà nella pentola di ghisa coperta. Per 25 minuti danzerà nel bollore continuo, trascinando nei vortici e nella schiuma – come dei tritoni che giocano attorno a un nero anfitrite – una ventina di lardelli, mezzi grassi, mezzi magri, che arricchiscono la cottura. Nessun’altra spezia! E abbasso il tovagliolo che puzza di cloro, ultimo giaciglio del tartufo cotto! I vostri tartufi arriveranno in tavola nel loro brodo di cottura. Servitevi senza parsimonia; il tartufo è aperitivo e digestivo.” Colette detesta che i deliziosi tuberi vengano serviti a fette, ‘in trucioli’ o tritati, a meno che non servano per steccare la carne. Una parte del sugo di cottura viene versata dentro ai bicchierini da liquore per essere bevuta.
D’inverno, si concede a volte una vacanza in montagna. Vacanza per modo di dire, dato che, per lei, la vacanza vuol dire spesso solo cambiare posto di lavoro. A Gstaad, per esempio, tenta di sciare. Ma quando vede che i capitomboli, con atterraggio sul fondoschiena, sono più numerosi dei tratti percorsi sugli sci, opta per la tavola, dove si siede con gli amici che vengono a trovarla.
Negli anni ’40 e ’50 è ormai famosa e viene invitata in Germania, in Belgio e in Romania a tenere delle conferenze. Sono delle tournée trionfali con interviste, fotografie, banchetti in presenza di re, presidenti e ambasciatori. A Bruxelles, dopo la cerimonia di assegnazione della Legion d’onore, va con gli amici nel migliore ristorante della città, dove consuma i suoi pasti l’élite dell’Europa e dove vengono serviti i migliori cru d’Europa. Ancora una volta la scrittrice suscita scandalo, sia per il suo aspetto – ha i piedi scalzi nei sandali e le unghie laccate di rosso – sia per la sua richiesta di una dozzina di bottiglie di Krieken-Lambic, la birra popolare a base di orzo e di frumento mescolati alle ciliegie Schaerbeck, che si beve solo nelle bettole, da portare a Parigi.
A New York, dove è accolta trionfalmente, si verifica un episodio curioso. Al banchetto ufficiale con il sindaco Fiorello La Guardia ci sono 800 invitati. L’invito della scrittrice, che appare sotto il nome di signora Goudeket, porta il numero 799, quello di Maurice 800. Colette, furiosa, decide, forse per la prima e unica volta in vita sua, di non andare né al banchetto ufficiale né a quello degli scrittori. Va in giro per la città a fare la turista.
Quando è costretta a letto dall’invalidità, fa in modo che siano i sapori della campagna che arrivano a lei.
“Dell’aglio, delle cipolle bianche, del sale grosso, del pepe sul formaggio bianco appena rappreso, del muscadet ben fresco e delle ciliegie… Quando non si può fare di meglio, è un modo di andare in campagna.”
“Colette amava gli uccellini. Di sicuro aveva un’ammirazione per quelli che vedeva dalla sua zattera. Non ha forse scritto: ‘Il passerotto questo pedone’? A quelli non voleva alcun male. Allo stesso tempo, però, passeri, allodole o ortolani, preferibilmente sotto forma di pasticcio, si addicevano mirabilmente alla sua idea di gastronomia. Perché lei aveva delle opinioni ben definite in proposito e io le rispettavo.” ha scritto di lei Raymond Oliver, che ha trascritto la ricetta del suo adorato pasticcio di allodole.
“Contate 6 uccelli per 2 persone. È difficile preparare un pasticcio per una sola persona. Disossare completamente gli uccelli e metterli a marinare per qualche ora mentre li si condisce, spruzzandoli di Armagnac giovane e sbriciolandovi sopra qualche fiore di timo. Fare una farcitura con della carne di maiale, del grasso di prosciutto essiccato e del pollame, in parti uguali. Condire con un po’ di nigella, sale e pepe. Si deve usare moderazione nel condire. Tagliare tanti dadini di foie gras e di tartufi quanti sono gli uccelli. Preparare una pasta sfoglia o una pasta frolla per il fondo e una pasta sfoglia per il coperchio. Regolarsi come per una torta Pithiviers. Uno strato di ripieno, uno strato di uccelli farciti con un dado di foie gras, disposti a corona, poi la trama. Ricoprire con ripieno e con la pasta. Chiudere bene. Dorare. Cuocere in forno allegro per 30 minuti. Lasciare in forno tiepido per 15 minuti, e servire. Potete accompagnarlo con una piccola salsa o, molto semplicemente, con della panna alla quale sarà stato aggiunto un po’ di burro fuso. Il tutto condito e montato.”
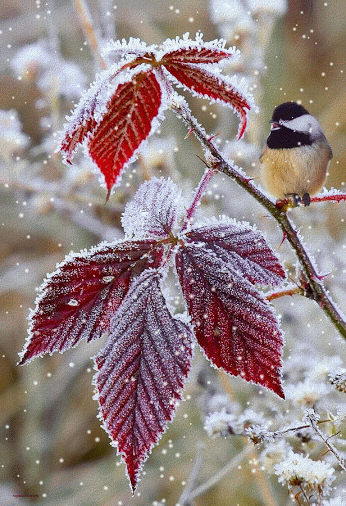 Amare gli uccellini - fino alla fine dei suoi giorni ha continuato a mettere sul davanzale il cibo per i passeri, a osservarli in giardino, a intenerirsi per loro quando fuori c’era la neve - e gustarli cotti in tavola è stata una delle sue contraddizioni. Oltre agli uccellini, amava molto anche i polli.
Amare gli uccellini - fino alla fine dei suoi giorni ha continuato a mettere sul davanzale il cibo per i passeri, a osservarli in giardino, a intenerirsi per loro quando fuori c’era la neve - e gustarli cotti in tavola è stata una delle sue contraddizioni. Oltre agli uccellini, amava molto anche i polli.“Ho conservato per ultima la ricetta di un pollo all’argilla e alla cenere… - scrive in Prisons et paradis - Sembra barbarica. Ricorda quella del pollo cinese, sigillato nella lacca, salvo che il pollo alla cenere richiede che lo si avvolga nell’argilla levigata, la creta degli scultori, con tutte le sue penne. Bisogna solo svuotarlo con cura, salarlo e peparlo. Per tutto il resto è sufficiente il suo grasso. La palla di argilla e il suo nocciolo gallinaceo subiscono una cremazione abbastanza lunga. In capo a tre quarti d’ora, nelle braci attizzate e rinnovate, la molle argilla si trasforma in un uovo di terracotta. Quando lo si rompe, le penne restano attaccate al coccio e a voi si offre la perfezione selvaggia del tenero pollo che vi inclina verso una ghiottoneria un po’ brutale e preistorica…”
L’ultimo ‘viaggio gastronomico’, molto breve, lo fa il giorno del suo ottantesimo compleanno per andare a mangiare, nello stesso ristorante, la lepre alla royale. “Chi di voi lettrici, assaporando la vera lepre alla royale, che si scioglie in bocca, sospetterebbe che sessanta – avete letto bene, sessanta - spicchi d’aglio abbiano cooperato alla sua perfezione? Una lepre alla royale ben riuscita non ha il gusto di aglio. Sacrificati a una gloria collettiva, i sessanta spicchi d’aglio, irriconoscibili, sono tuttavia presenti, indiscernibili, colonne che sostengono una flora abbarbicata e leggera di spezie casalinghe…”.

